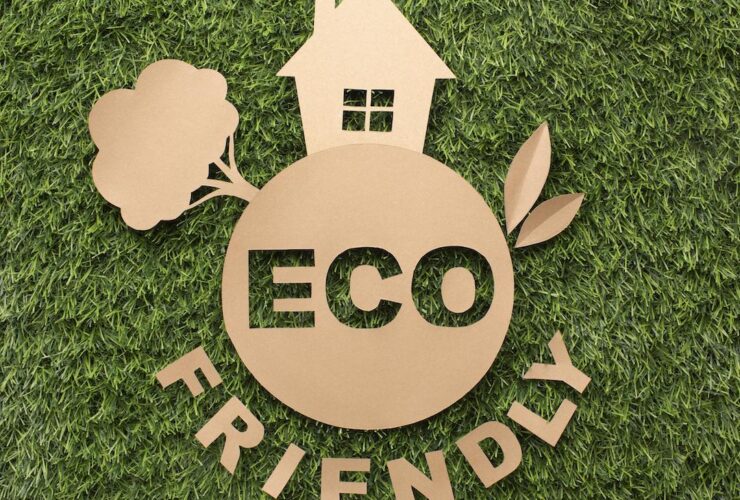Brevetto e segreto industriale su prodotti agroalimentari: ecco il terzo di cinque articoli sulla tutela della proprietà intellettuale nel settore alimentare.
Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?
Avete messo a punto un procedimento innovativo che consenta di ottenere dei succhi concentrati in modo efficiente, o addirittura un prodotto del tutto originale?
Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri si approprino illecitamente dell’idea.
Gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale
L’ordinamento italiano ed euro-unitario (in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti per tutelare il frutto del proprio ingegno, da intendersi in senso ampio fino a ricomprendere le strategie di marketing e commerciali.
Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale, del copyright, delle varietà vegetali e, infine, del segreto industriale.
Come dicevamo, in questo articolo l’attenzione sarà concentrata, in particolare, sul brevetto e sulla tutela del segreto industriale (o know how).
I brevetti
Cosa sono
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito, su un determinato territorio, un monopolio temporaneo di sfruttamento economico (produzione, importazione, esportazione, vendita, o attuazione del procedimento) su un’invenzione.
L’invenzione è definita come una soluzione innovativa ad un problema della tecnica. Essa può consistere in un prodotto o in un procedimento industriale. Esistono anche i brevetti per modelli di utilità: nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili, loro combinazioni e configurazioni.
Sono brevettabili (art. 45 del Codice della Proprietà Industriale – CPI) solo quelle idee che siano:
- nuove (non ricomprese nello “stato della tecnica” a livello mondiale);
- non ovvie (non banali per un tecnico medio del settore di riferimento);
- lecite;
- suscettibili di applicazione industriale (riproducibili “meccanicamente” da chiunque e non legale alla particolare competenza o perizia di un tecnico).
Durata e costi
I costi di un brevetto, in genere, sono di gran lunga più elevati di quelli richiesti da un qualsiasi altro titolo di diritto industriale, visto che è necessaria l’attività di tecnici molto qualificati (es. ingegneri chimici, meccanici che siano altresì formati sulla materia brevettuale) onde predisporre la relativa domanda.
Va poi considerato che l’ambito geografico di tutela è ristretto allo Stato in cui è presentata la domanda. Ciò significa che per proteggere la propria invenzione in un altro Paese, è necessario effettuare presso l’ufficio competente (nella lingua ufficiale) una nuova domanda di brevetto.
Esiste anche la possibilità riconosciuta dal Patent Cooperation Treaty, che ha istituito una procedura che consente di “prenotare” il proprio brevetto in altri Stati che hanno aderito al trattato internazionale in parola, partendo da un’unica domanda.
Interessante poi l’imminente brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”), che sarà rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all’iniziativa.
La durata di un brevetto, infine, è limitata nel tempo: 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato alla scadenza (lasciando da parte l’ambito farmaceutico che ha delle peculiarità).
I brevetti nel settore agro-alimentare
Il settore agro-alimentare, come ogni altro, è interessato da invenzioni brevettabili sia di prodotto che di processo.
Si possono brevettare, per esempio, sostanze che diano caratteristiche particolari all’alimento: meno zuccheri rispetto ai prodotti simili, maggior digeribilità, maggior conservazione, maggior facilità di cottura, ecc.
Molte applicazioni riguardano gli additivi, come quelli ottenuti da matrici naturali evitando la sintesi chimica oppure altri che garantiscano la rintracciabilità e prevengano le frodi.
Innumerevoli i brevetti di processo, poiché è sempre più attuale la sfida per ottenere alimenti più sani, più sicuri, sprecando meno risorse e garantendo il benessere animale.
Un settore in fermento è certamente quello degli integratori alimentari, in cui le aziende cercano di farsi strada proponendo prodotti con profili nutrizionali migliori, ricchi di vitamine e sali minerali e ottenuti con nuovi procedimenti produttivi.
Meno prolifico, invece, per ragioni regolatorie, ma anche per la naturale diffidenza dei consumatori europei, è il versante degli O.G.M., dei nano–alimenti e della clonazione animale.
Innovazioni brevettabili e novel food
Molto spesso l’innovazione nel settore agro-alimentare si scontra con la disciplina novel food (regolamento (UE) n. 2015/2283), di cui abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.
Ricordiamo brevemente che i novel food sono alimenti che non possono vantare un consumo sicuro e significativo nell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997, data in cui è entrato in vigore il primo regolamento in materia [regolamento (CE) n. 258/1997]:
- con struttura molecolare nuova o volutamente modificata (es. sintetizzati chimicamente);
- costituiti, isolati o prodotti da matrici vegetali, animali, unicellulari, minerali, fungine, ecc. (vi rientrano cibi derivanti da animali clonati);
- risultato di un nuovo processo di produzione che comporti variazioni significative alla composizione/struttura, tali da incidere su valore nutritivo, metabolismo o tenore di sostanze indesiderabili;
- nanofoods (costituiti da nanomateriali ingegnerizzati);
- utilizzati esclusivamente in integratori alimentari fino a. 15.5.97, se destinati ad uso diverso;
- che derivano direttamente da piante o animali di Paesi terzi, ove sono stati consumati abitualmente in sicurezza per almeno 25 anni da un numero significativo di persone.
Non sempre un’idea brevettabile dà luogo ad un novel food, ma le probabilità sono piuttosto elevate, con conseguente freno per l’azienda innovatrice, la quale si trova tra le mani un prodotto potenzialmente vincente, ma non commercializzabile nell’immediato.
Per contro, non sempre un novel food nasce da un brevetto: basti pensare all’ormai famosa e di recente autorizzata “farina di tarma” (tenebrio molitor).
La tutela del segreto industriale o del know how
Un’idea, sia essa brevettabile o meno, può essere tutelata virtualmente per sempre e a costi irrisori finché rimane segreta e abbia un valore economico. Parliamo in questo caso di segreto industriale.
Al di là dei costi che un brevetto comporta, vi è un’ulteriore considerazione su cui riflettere: i brevetti sono pubblici, accessibili gratuitamente a chiunque e contengono l’esatta descrizione dell’idea tutelata. Da un lato, quindi, viene concesso un monopolio provvisorio, dall’altro, però, chiunque può partire da quella idea e trarre ispirazione per una propria invenzione, a patto di non violare la privativa del titolare.
Ecco perché vi sono casi in cui è consigliabile mantenere la propria innovazione segreta, al fine di conservare un vantaggio competitivo sui concorrenti.
Cos’è il segreto industriale
Il “segreto aziendale o industriale” (artt. 98-99 CPI) può sintetizzarsi nelle informazioni strategiche riguardanti l’attività produttiva o organizzativa di un’impresa e che sono suscettibili di valore economico proprio in virtù della loro segretezza (forniscono cioè un vantaggio competitivo), che viene garantita da misure adeguate.
Esiste anche il segreto commerciale, i cui presupposti sono i medesimi di quello industriale, ma fa riferimento ad informazioni riservate che ricadono, appunto, nella sfera commerciale dell’azienda (es. liste clienti).
È assolutamente importante che sussista la volontà di mantenere la segretezza delle informazioni, nonché l’interesse al riserbo, poiché deve trattarsi di informazioni che non siano già di dominio pubblico e neppure così banali da non fornire un vantaggio competitivo.
La tutela ha carattere sia penalistico (art. 623 c.p.), che civilistico (atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., responsabilità contrattuale per violazione di accordo di riservatezza, ecc.) ed in tal caso si può pretendere ed ottenere il risarcimento del danno subito.
Come si tutela il segreto industriale
Al fine di tutelare le informazioni aziendali strategiche, si deve procedere ad “erigere” barriere materiali e/o giuridiche, che ne limitino accesso e diffusione.
Preliminarmente, occorre individuare esattamente quali conoscenze siano da secretare. È chiaro, infatti, che una classificazione aspecifica, che contrassegni come segrete tutte le informazioni, faccia perdere valore all’indicazione stessa.
Successivamente, si andranno a strutturare misure endoaziendali e misure esoaziendali.
Misure endoaziendali
Le misure endoaziendali riguardano i rapporti interni all’azienda e impediscono la divulgazione delle informazioni a coloro (dipendenti, collaboratori stabili, ecc.) che non sono titolati a conoscerle:
- zone non accessibili dell’azienda (es. uffici o armadi chiusi a chiave);
- aree del server permesse solo ad a chi è abilitato tramite password o altri mezzi;
- procedure che delimitino la circolazione di documenti sensibili solo a certi dipendenti;
- segmentazione dell’attività produttiva per far sì che nessun dipendente conosca l’intero processo produttivo (es. la ricetta) in dettaglio;
- corsi di formazione interni sull’importanza e sulle modalità di tutela dei segreti industriali dell’azienda;
- codici di condotta.
Misure esoaziendali
Le misure esoaziendali impediscono ogni divulgazione di informazioni segrete, eccetto verso coloro che abbiano sottoscritto accordi di riservatezza:
- contratti con clausole di riservatezza e non divulgazione;
- non discosure agreement– NDA da far sottoscrivere a consulenti, fornitori, clienti, ecc.;
- patti di e non concorrenza con consulenti e dipendenti una volta cessato il rapporto;
- materiale informativo (es. brochure, fiere, eventi, sito web) e comunicazioni supervisionate da responsabile della segretezza;
- sistema IT in grado di tutelare i segreti da minacce esterne;
- oscuramento delle attività sensibili dell’azienda in occasione della visita di terzi;
- misure per tutelarsi da spie industriali (telecamere, sorveglianza, investigatori interni, ecc.).
Il segreto industriale nel settore agro-alimentare
Nel settore del food & beverage, oggetto di protezione tramite segreto industriale possono essere:
- il processo produttivo;
- la composizione del prodotto.
Se il primo elemento è intuitivo, meno lo è il secondo.
Come noto, il regolamento (UE) n. 1169/2011 impone (artt. 9-10) una serie obblighi informativi da riportare nell’etichettatura dei prodotti preimballati, tra cui, per quanto qui rileva, la lista degli ingredienti adoperati in ordine ponderale descrescente. Tale informazioni può non comparire solo sulle bevande con tasso alcolemico superiore al 1,2 % di alcol in volume.
Come si concilia la possibilità di mantenere la segretezza della ricetta con il dovere di dichiarare gli ingredienti? E non sarebbe in ogni caso facile capire l’esatta composizione di un alimento mediante un’analisi bromatologica?
In primis, va evidenziato che non è prescritto di precisare il peso o la percentuale di ogni singolo ingrediente (eccetto i casi in cui si applica la regola del QUID).
In secondo luogo, la chiave del successo di molti prodotti, tra cui la “Coca-cola” sta negli aromi.
Gli aromi [Allegato VII, parte D, regolamento (CE) 1334/2008] possono essere designati anche solo scrivendo «aroma/i» accompagnato eventualmente dall’aggettivo «naturale» se sussistano i requisiti di cui all’art. 16. Non è dunque necessario precisare la sostanza da cui l’aroma è tratto [infatti nell’etichetta della Coca-Cola è scritto solo “aromi naturali (inclusa caffeina)”].