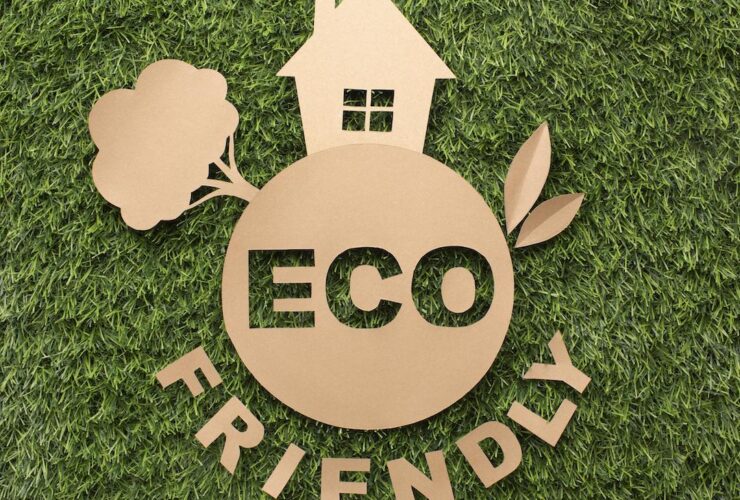Concorrenza sleale nel food & beverage: in quest’ultimo di cinque articoli sulla tutela della proprietà intellettuale, tratteremo appunto di una delle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore, in quanto è probabilmente quella dove si concentrano la maggior parte delle dispute e delle liti.
Dopo anni di ricerche, o per puro caso, avete elaborato la ricetta perfetta per una nuova “Coca Cola”?
Avete inventato un nuovo dolce combinando ingredienti esotici da ogni parte del mondo con un risultato inaspettato e straordinario?
O ancora avete scoperto che un raro frutto africano potrebbe fornire la base per un nuovo energy drink buono, sano e in grado di far tremare la “Red Bull”?
Bene, vediamo cosa si può fare per evitare che altri vi “rubino l’idea”.
AGGIORNATO A LUGLIO 2021
Gli strumenti di tutela della proprietà industriale
L’ordinamento italiano ed euro-unitario (in questo campo vi è un grado di armonizzazione molto elevato tra le legislazioni di tutti i Paesi del mondo) mettono a disposizione di un ideatore creativo diversi strumenti per tutelare il frutto del proprio ingegno, da intendersi in senso ampio fino a ricomprendere le strategie di marketing e commerciali.
Parliamo, in particolare, del marchio d’impresa, del brevetto, del disegno o modello ornamentale, del copyright, delle varietà vegetali e, infine, del segreto industriale.
Al di là dei singoli strumenti appositamente regolamentati, vi è poi un’area più ampia e indefinita che rientra nel concetto concorrenza sleale.
La concorrenza sleale nel food & beverage
Innanzi tutto, definiamone l’ambito di rilevanza soggettiva della concorrenza sleale: questa può aversi solo tra imprenditori che siano in rapporto di concorrenza economica anche solo potenziale.
Operata questa individuazione, la norma di riferimento (art. 2598 c.c.) prevede tre distinte fattispecie, sindacabili dal giudice ordinario in sede di contenzioso civile e imputabili a titolo oggettivo (non è necessario dimostrare l’elemento del dolo o della colpa):
-
comma 1: concorrenza sleale per confondibilità – servile per imitazione;
-
comma 2: concorrenza sleale per denigrazione / vanteria o appropriazione di pregi;
-
comma 3: violazione della correttezza professionale.
Concorrenza sleale servile per imitazione
La prima forma di concorrenza sleale è quella servile per imitazione, o per confondibilità, che si ha quando un’impresa sfrutta l’affermazione sul mercato di un prodotto di una concorrente, copiandone gli elementi distintivi ed individualizzanti, dotati cioè di notorietà qualificata, in modo fedele e pedissequo. Tra questi, rientrano non solo i diritti di proprietà industriale registrati, ma anche quelli non registrati (marchi di fatto, nomi o altri segni distintivi) e perfino quelli atipici (nome della ditta irregolare o nomi a dominio).

Quanto alla forma del prodotto originale, se non registrata tramite marchio di forma o modello, deve comunque risultare: nuova, distintiva (non banale o standardizzata), nota presso il pubblico di riferimento, non funzionale rispetto all’utilizzo del prodotto medesimo e non meramente ornamentale.
Obiettivo di chi pone in essere questa forma di concorrenza sleale è “agganciare” il proprio prodotto alla fama e alla notorietà di quello originale, inducendo così i consumatori a ritenere che essi siano riconducibili alla stessa azienda e beneficiando di un “traino” commerciale del tutto indebito.
Giudizio di confondibilità
A tal fine il giudice chiamato a decidere sulla controversia opererà un “giudizio di confondibilità” alla luce di tutti gli elementi di fatto che, nel caso specifico, accompagnano la presentazione del prodotto, conducendo un esame sintetico, ottenuto cioè basandosi sulle impressioni di massima generate in un consumatore medio da percezioni sensoriali immediate e superficiali.
Più precisamente, si andrà a valutare la potenzialità confusoria degli atti posti in essere dall’agente, ossia la loro idoneità a suscitare confusione nel consumatore mediamente avveduto destinatario dei beni imitati circa la loro origine commerciale, in termini di ragionevole probabilità.
Si ricorda che l’azione relativa all’accertamento della concorrenza sleale per imitazione servile (con la pretesa risarcitoria) è indipendente e cumulabile rispetto a quella di contraffazione di un titolo di proprietà industriale, che ha presupposti diversi. Basti solo menzionare che per essa è sufficiente un giudizio di confondibilità in astratto, ovvero prescindendo dalle modalità specifiche con cui il segno è portato all’attenzione dei potenziali consumatori, e dunque anche se, in concreto, sussistano altri elementi differenzianti che possano escludere la confondibilità.
Denigrazione e appropriazione di pregi
La seconda ipotesi è rappresentata in realtà da due comportamenti ben distinti:
- atti di concorrenza sleale per denigrazione, che si realizza mediante diffusione pubblica di giudizi negativi e del tutto in mala fede di un concorrente o dei suoi prodotti;
- atti di vanteria/appropriazione di pregi, fattispecie che consiste nell’evidenziare qualità determinanti per le scelte di acquisto dei consumatori in realtà non sussistenti.
Anche la concorrenza sleale per appropriazione di pregi prevede un’operazione di “agganciamento” del consumatore ma, a differenza che nella prima fattispecie, non vi è un caso di imitazione di un prodotto con le sue specifiche caratteristiche tecniche od ornamentali, bensì la millanteria di qualità (dell’azienda e/o del prodotto) da altri realmente possedute ed essenziali per le scelte d’acquisto.
Italian sounding
Si pensi al noto fenomeno dell’“italian sounding”, ovvero l’impiego di nomi dal suono vagamente italiano, accompagnati da colori e immagini
 tipiche del nostro Paese, su prodotti che, con l’Italia, non hanno nulla a che fare. L’appropriazione di pregi si realizza appunto alludendo ad un’origine non veritiera di cibi e bevande, con lo scopo di convincere l’ignaro consumatore che possiedano quelle qualità generalmente attribuite agli alimenti “made in Italy”.
tipiche del nostro Paese, su prodotti che, con l’Italia, non hanno nulla a che fare. L’appropriazione di pregi si realizza appunto alludendo ad un’origine non veritiera di cibi e bevande, con lo scopo di convincere l’ignaro consumatore che possiedano quelle qualità generalmente attribuite agli alimenti “made in Italy”.
Look alike
I casi di “look alike” (il prodotto concorrente ha forme, colori, carattere tipografico, etichette, immagini o altro, tali da indurre i consumatori a ritenere che esso appartenga all’impresa originale), non infrequenti nel settore del cibo, rientrano senza dubbio nell’operatività della tutela contro la concorrenza sleale e, a seconda dei casi, possono essere assimilati o alla prima o alla seconda delle due fattispecie fin qui esaminate (imitazione servile o indebita appropriazione di pregi).
Correttezza professionale
Infine, l’ultima ipotesi di concorrenza sleale è la violazione della correttezza professionale, formula ampia di chiusura che racchiude varie fattispecie non disciplinate nei primi due commi dell’art. 2598 c.c., ma dotate di una autonoma rilevanza, quali:
- concorrenza parassitaria;
- messaggi ingannevoli ai consumatori;
- spionaggio industriale e violazione di segreto industriale e commerciale;
- dumping;
- storno di dipendenti;
- boicottaggio, violazione di patto di non concorrenza, conflitto d’interessi non dichiarato ecc.
Ci soffermeremo brevemente sui primi due punti (il terzo, che riguarda la violazione di segreto industriale ex artt. 99-100 C.P.I. è stato trattato separatamente).
Concorrenza sleale parassitaria
Il primo punto è la c.d. concorrenza sleale parassitaria, caratterizzata da una illecita appropriazione dei risultati commerciali ottenuti da un’impresa concorrente, idonea ad arrecare danno a quest’ultima.
Più nello specifico, la condotta è integrata da un’imitazione sistematica, commessa mediante plurimi atti protratti nel tempo, dell’attività commerciale, delle iniziative, delle strategie e degli investimenti del concorrente.
Non è necessario che vi sia confondibilità sull’origine dei prodotti, in quanto vero scopo di questa forma di concorrenza sleale è sfruttare a proprio vantaggio la creatività, le iniziative e le strategie altrui di successo, risparmiando tempo e risorse (ad esempio per sviluppare nuovi prodotti o fare ricerche di mercato).
Per questa ragione, non è richiesto nemmeno un rapporto di concorrenza diretta tra danneggiante e danneggiato, i quali potrebbero operare in settori merceologici diversi.
Gli atti di imitazione potrebbero essere posti in essere, singolarmente, a breve distanza temporale dai corrispondenti atti “originali” (concorrenza parassitaria diacronica), oppure verificarsi in un unico momento, a stretto giro dell’attività più significativa del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica). Per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo nel quale l’innovatore ha ragione di aspettarsi utilità particolari dal lancio della sua proposta commerciale: si pensi al caso di iniziative che facciano breccia tra i consumatori al punto da catalizzarne gli acquisti.
Pubblicità menzognera
Una seconda ipotesi di scorrettezza professionale è incarnata dalle pratiche commerciali ingannevoli ai sensi del Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005, art. 20), caratterizzate per essere contrarie alla correttezza professionale e false, ossia idonee a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che, senza di esse, non avrebbe preso.

Tipico caso, in materia alimentare, è quello di indicazioni nutrizionali, sulla salute o sull’origine erronei, o il vanto di proprietà non possedute o comunque non fondate scientificamente, o ancora l’evidenza data a caratteristiche comune a tutti gli altri prodotti della stessa tipologia (es. un tè vegano, un succo di frutta “senza glutine”, uno snack con cereali e frutta secca “senza lattosio”, un integratore alimentare a base di estratti botanici “cruelty free”, un alimento biologico “OGM free”, ecc.).
Ancora, recentemente, vi è tutta la tematica sulla sostenibilità ambientale, per la quale vengono riportati messaggi su quanto i prodotti o i processi aziendali siano rispettosi dell’ambiente, senza tuttavia che vi siano le basi per poterlo fare, oppure perché, accanto ad aspetti realmente positivi, ve ne sono altri che non lo sono affatto e vengono taciuti o posti in minor rilievo.
Sul punto si veda questa nostra guida.
La pubblicità menzognera, infatti, è caratterizzata da una «(astratta) capacità di falsare il gioco della concorrenza sul mercato, dunque di orientare i consumatori al momento della scelta dell’operatore cui rivolgersi, a prescindere dal fatto che poi, in concreto, l’offerta decettiva sia, comunque, più conveniente, poiché è il messaggio promozionale che “aggancia” il consumatore, ed ha, quindi, potere “sviante”» (Trib. Milano, Sentenza dell’8.8.2018, n. 8622/2018).
Similmente, sono riconducibili alla medesima fattispecie le pubblicità comparative illecite [cfr. d. lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa e regolamento (CE) 1924/2006 (regolamento claim)], che in ambito alimentare sono frequenti e richiedono una particolare attenzione (vedi questo nostro intervento a proposito).
La nuova disciplina speciale sulla concorrenza sleale nella filiera agro-alimentare
Il Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, oltre ad intervenire sulla “Riforma della Giustizia Penale”, ha provveduto all’attuazione della direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n.53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Gli obiettivi della nuova disciplina sono, essenzialmente, quello di garantire una maggior tutela dei fornitori e degli operatori “deboli” della filiera agricola e alimentare prima, durante e dopo la relazione contrattuale, cercando di evitare per quanto possibile accordi capestro e vendite sottocosto, oltre che un generale aumento della trasparenza anche a beneficio dei consumatori.
Ciò attraverso la definizione di un elenco di pratiche commerciali sleali sempre vietate (c.d. black list) ed un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della formalizzazione dell’accordo, oltre che un generale aumento della trasparenza anche a beneficio dei consumatori.
Su queste tematiche, l’autorità di controllo nazionale designata è l’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali).
Ne abbiamo parlato approfonditamente qui.
Le azioni a tutela
La vittima di pratiche commerciali ingannevoli ha a disposizione più azioni per tutelare la propria posizione giuridica: innanzi al giudice civile, attivando il Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria e presentando un esposto all’Antitrust (AGCM).
I tre tipi di tutela sono cumulativi ed indipendenti, anche se è prevista la possibilità di chiedere ad AGCM la sospensione del procedimento se della questione è stato investito il Giurì di Autodisciplina pubblicitaria (art. 27 ter C.d.C.).
Azione civile
La prima e più intuitiva è l’azione civile innanzi al giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d’appello aventi sede in ogni capoluogo di Regione) per il risarcimento del danno derivante da concorrenza sleale nei confronti tanto di altre imprese che dei consumatori.
Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Se la pratica è avvenuta per mezzo di una campagna di comunicazione, è possibile segnalare la pubblicità illecita al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), a patto che il danneggiante abbia aderito al relativo Codice di Autodisciplina (una strada conveniente in quanto molto rapida e totalmente gratuita). Il Giurì applicherà appunto le disposizioni del suddetto codice, il quale prevede, per esempio, che la comunicazione commerciale debba evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto (art. 2). Si segnala inoltre, che la violazione dei precetti del Codice può integrare l’art. 2598 n. 3 c.c. (con relativa possibilità di adire il giudice ordinario).
L’Antitrust
Ancora, può essere presentato un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale applica gli artt. 20 e 21 del d. lgs. 205/2005 – Codice del consumo – integrato dal d. lgs. 146/2007 relativo alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (ingannevoli o aggressive) e il d. lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole o comparativa illecita.
L’Autorità applica apposite linee guida sulle sanzioni secondo il regolamento di procedura specifico, col risultato che può comminare sanzioni pecuniarie fino ad € 5.000.000 per pratiche scorrette verso consumatori di cui al Codice del Consumo e fino ad € 500.000 per pubblicità ingannevole e comparativa.